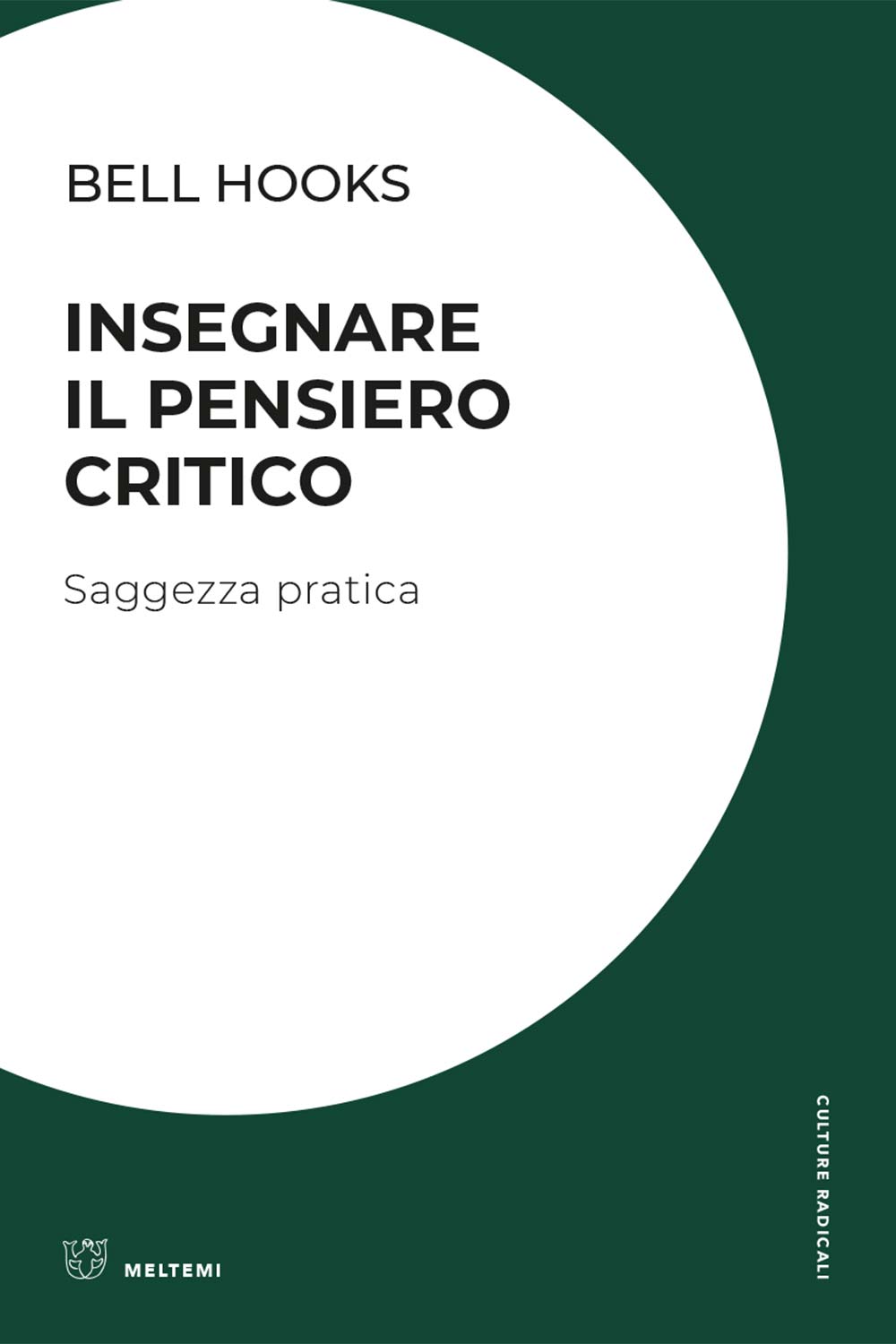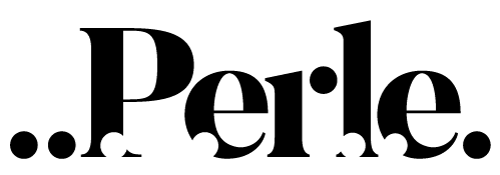bell hooks. Il tempo per piangere
Un estratto dal volume di bell hooks Insegnare il pensiero critico. Saggezza pratica, Casa editrice Meltemi 2023, collana Culture Radicali. L’estratto è comparso su Minima&Moralia.
[Immagine: BLM protest 2020]
bell hooks, Il tempo per piangere. Quando in classe si affrontano argomenti difficili, intimamente collegati alla “vita reale”, c’è sempre il rischio che qualche studente scoppi in lacrime. Nelle aule di molti professori neri, la studente piagnona solitamente è bianca. Una collega nera e femminista mi ha chiesto di affrontare questo problema, definendolo in modo ostile come la “sindrome della bianca che piange”. Quando si discute delle dinamiche razziali tra bianchi e neri le lacrime si manifestano spesso in classe, perché rappresentano vergogna e senso di colpa; quando si parla di razza non è possibile mantenere la distanza emotiva che invece persiste nei confronti di altri argomenti meno pesanti.
Più di trent’anni fa, quando cominciai a tenere corsi incentrati sui romanzi delle scrittrici nere, un’intensa risposta emotiva al racconto che stavamo leggendo era praticamente inevitabile, e portava alle lacrime sia le studenti bianche sia quelle nere. Le nere piangevano perché, per la prima volta, un romanzo dava voce al dolore del razzismo interiorizzato che demolisce l’autostima delle giovani nere, rendendolo pubblico. Certamente, questo è ciò che Toni Morrison ha affermato essere il catalizzatore della sua scrittura in occasione del suo primo romanzo L’occhio più azzurro; la consapevolezza che, almeno in quel momento, i libri che mettevano al centro le storie delle ragazzine nere erano pochi. Le studenti bianche che non sapevano dell’esistenza di un sistema di caste di colore tra i neri o che, se lo sapevano, non avevano mai realizzato appieno il suo impatto sul corpo e sull’esistenza dei bambini neri, piangevano perché erano sopraffatte dalla narrazione di un simile dolore.
Alcuni professori considerano le lacrime delle ragazze bianche come una richiesta di attenzione o una distrazione, che fa deragliare la discussione in classe. In alcuni momenti succede, intenzionalmente o meno. È importante sottolineare che, quando una studente piange, è l’insegnante che deve discernere se quelle lacrime siano utili ad alimentare una discussione più profonda in classe o se rappresentino un’intrusione. Il modo migliore per operare questa distinzione è conoscere i propri studenti, osservare fin dalla prima lezione i diversi modi in cui i singoli individui reagiscono. A volte la causa del dolore è esterna alla classe, e le parole pronunciate in classe possono semplicemente innescare quelle emozioni.
Nel corso dei miei anni adolescenziali, segnati da una profonda infelicità, mi ritrovavo spesso a piangere silenziosamente durante una lezione di storia che si teneva nel tardo pomeriggio. Intorno a me, sia gli altri studenti sia l’insegnante fingevano di non accorgersene. Il liceo era stato desegregato di recente. Per questo motivo, gli studenti neri erano costretti ad alzarsi prima del solito e andare in autobus alla scuola “bianca” dove ci avrebbero fatti ammassare in palestra, costringendoci ad aspettare l’arrivo degli studenti bianchi, in modo da farli entrare per primi nella scuola. La logica suprematista bianca riteneva che questo fosse il modo di mantenere la pace. Nonostante la presenza della Guardia Nazionale e di poliziotti bianchi armati, l’integrazione era avvenuta senza incidenti ed era vitale per gli amministratori che non si verificasse alcun incidente razziale. Non c’è da stupirsi, quindi, che in un’aula tutta bianca, con solo altri due studenti neri presenti, nessuno volesse riconoscere i miei sentimenti, il mio dolore.
Quando gli insegnanti affrontavano la questione del mio crollo emotivo, lo mettevano in relazione alla mia vita domestica. Una volta il mio psicologo mi chiese se questa lezione avesse luogo poco prima del mio ritorno a casa. Eppure nessuno voleva affrontare quell’argomento. Malinconia, suicidio, qualunque fosse il mio stato emotivo, ritenevano fosse meglio ignorarlo. Dato che pensavo spesso al suicidio, immaginavo i discorsi che avrebbero pronunciato se mi fossi davvero uccisa. Qualcuno avrebbe ricordato le molte volte in cui sedevo in classe apparentemente sopraffatta dal dolore. A casa, ero nota per i miei pianti infiniti, mentre i miei sei fratelli non piangevano mai. Per prendermi in giro, mi avevano soprannominato Jean Autry, l’attrice nota per le sue interpretazioni nel ruolo della “ragazzina ricca e sfortunata” che spesso si lasciava andare a intense crisi di pianto. Giunta alla scuola di specializzazione non piangevo più, avevo messo da parte il mio dolore, nascosto da un’intensa rabbia verso la cultura dominante e le persone che si assicuravano di mantenere lo status quo.
Quando iniziai a insegnare, vedere gli studenti dei miei corsi reagire alle letture o alle discussioni con lacrime appassionate mi faceva tornare alla mente il modo in cui il mio pianto era stato semplicemente ignorato. Non volendo sminuire le emozioni dei miei studenti, bianchi o neri, ho scelto di non ignorare le loro lacrime e mi sono impegnata al fine di usare quell’intensità emotiva per alimentare la consapevolezza dell’argomento che stavamo affrontando. Come ogni docente, in particolare donna, non voglio piangere davanti ai miei studenti. In quanto donne – e, ancor di più, quelle di noi che si avvicinano al lavoro accademico da una prospettiva femminista – siamo particolarmente consapevoli del perdurare delle idee sessiste, e di non essere considerate intellettualmente al pari degli uomini. La mentalità sessista dà per scontato che a tutte le donne capiti, prima o poi, di sentirsi emotivamente sopraffatte, di “crollare”, a riprova della nostra supposta inferiorità. Non volendo rafforzare un simile pensiero sessista, la maggior parte delle docenti fa di tutto pur di non versare mai una lacrima in classe.
La scrittrice e attivista Tillie Olsen ha tenuto il primo corso di Women’s Studies che ho frequentato all’università. A volte, nel mezzo delle sue toccanti divagazioni sull’ingiustizia di essere costretta a lottare contro la povertà, una maternità non scelta e un marito rude, cominciava a piangere. Devo confessare che raramente ero commossa dalle sue lacrime, perché sembravano emergere proprio in quei momenti in cui la sua “prospettiva” sulla vita delle donne veniva messa in discussione in modo critico. Avevo ribattezzato quelle lacrime il sequel de “Nascita di una nazione – il pianto della ragazzina bianca tormentata” e le consideravo l’espressione di un sentimento banale. E naturalmente, nella mia arroganza di universitaria, quando parlavo con gli altri studenti di queste manifestazioni pubbliche di emozione dopo la lezione, insistevo sul fatto che le sue lacrime non avessero posto in classe; ci distraevano dalla lettura e dalla discussione critica. James Baldwin, scrittore nero e critico culturale, una volta ha spiegato che “il sentimentalismo è l’ostentazione di emozioni eccessive e pretestuose […], il segno della disonestà, l’incapacità di sentire”. Questa definizione descrive brillantemente i falsi sentimenti che vengono evocati da lacrime versate per manipolare emotivamente il pubblico.
Essere l’unica studente nera nella maggior parte dei corsi mi ha insegnato che esprimere il mio disaccordo nei confronti di una studente bianca avrebbe potuto portarla alle lacrime, facendola diventare così il centro dell’attenzione e della compassione di tutti, distogliendo l’attenzione generale dall’oggetto del contendere. Sapevo che le lacrime possono essere usate come arma di distrazione, e sono stata vittima della rabbia potente che si esprime attraverso le lacrime. Quando tale ricatto emotivo avviene in classe, anche questo può essere uno strumento di insegnamento.
Al City College di Harlem, ho tenuto un seminario su James Baldwin con studenti che provenivano da contesti incredibilmente diversi. Una delle studenti più intelligenti e impegnate della classe era una giovane, bianca e bionda, che proveniva dall’Islanda. Un giorno, stavamo leggendo un passo autobiografico di Baldwin, nel quale raccontava di essere stato picchiato duramente da suo padre. In classe, si scatenò una discussione, in cui ci si chiedeva se la punizione corporale dei bambini fosse accettabile. Una donna nera adulta, madre e single, disse: “Ho un figlio e devo picchiarlo. Deve capire come va il mondo o finirà per morire in queste strade malfamate, ucciso da un poliziotto bianco”. Uno studente nero raccontava di come sua madre lo avesse picchiato con qualsiasi cosa a portata di mano – una scopa, un ferro da stiro, una lampada – affermando che non l’avrebbe mai perdonata.
In mezzo a questa intensa discussione la giovane studente nordica, bionda e con gli occhi azzurri, nonché sposata e madre di due figli, scoppiò in lacrime e corse fuori dalla classe con un’espressione di orrore sul viso. In quel momento dovetti fare una scelta, concentrarmi sulle sue lacrime o riportarci alla discussione del testo di Baldwin integrando in essa le questioni sollevate dalle storie personali. Scelsi la seconda, per via dello sguardo di orrore sul suo viso, reputando fondamentale non permettere al giudizio negativo implicito nella sua reazione di distogliere l’attenzione dalla questione. Non volevo alimentare il presupposto, in una classe prevalentemente nera, che l’interpretazione bianca dell’esperienza nera conti maggiormente. Poi, mentre la discussione procedeva, chiesi a un altro studente di andarla a cercare, e sincerarsi se si fosse calmata. Una volta tornata in classe, si mise a raccontare a questi newyorkesi induriti che nel suo paese i genitori possono essere arrestati per aver picchiato i loro figli. Per la lezione successiva assegnai agli studenti il compito di scrivere un testo di una pagina sui terribili pestaggi che Baldwin aveva ricevuto, e se questi ultimi avessero avuto un impatto positivo o negativo sulla sua crescita artistica.
Consapevolezza emotiva ed espressione delle emozioni hanno necessariamente un posto in classe. Eppure, la maggior parte degli insegnanti preferisce di gran lunga evitare il pianto o altre manifestazioni intense di sentimenti appassionati, poiché non sono formati a reagire in modo costruttivo quando si trovano di fronte a studenti che danno mostra di sentimenti travolgenti. Se l’intelligenza emotiva fosse valorizzata come parte essenziale del ruolo di insegnante, saremmo maggiormente preparati e faremmo buon uso delle emozioni in classe.
Anche agli insegnanti può succedere di portare le proprie emozioni in classe! Per quanto mi sia sforzata di non versare mai lacrime in classe, ci sono stati momenti in cui non sono stata in grado di reprimerle. Recentemente, stavo insegnando a un gruppo di studenti presso l’Università della California, Santa Cruz, dove ho studiato molti anni fa. Una delle mie compagne di allora, bianca, con la quale avevo avuto molti disaccordi, era diventata una docente che, come me, si occupava di questioni di razza, genere e classe. Poco prima della lezione, avevo appreso della sua morte prematura. Poco dopo, mi trovavo in quell’aula di Santa Cruz a più di vent’anni di distanza, dove gli studenti si erano riuniti per discutere del mio lavoro. Cominciai a parlare di dialoghi difficili, dei meravigliosi e inebrianti anni dedicati alla discussione delle teorie femministe, e parlai di Ruth, dei conflitti che avevamo avuto, dei compromessi che ne erano seguiti. Le lacrime mi riempivano gli occhi sempre più, fino quando scoppiai a piangere per la sua morte prematura, che mi ricordava quella di tante altre pensatrici critiche. Bettina Aptheker, che si era laureata con noi, era tra il pubblico, e ho notato che anche lei stava piangendo. Gli studenti avevano le lacrime agli occhi.
Era chiaro che questo momento di intensità emotiva imprevista aveva rappresentato una lezione commovente per gli studenti e aveva insegnato loro che anche da relazioni iniziate all’insegna della contestazione e del conflitto possono scaturire legami positivi, radicati nel rispetto e nell’affetto. Prima della mia lezione, gli studenti avevano ricevuto una dispensa che dettava il modo “corretto” di comportarsi, istruendoli a non interrompere, a non alzare la voce. Sembrava un manifesto per “la repressione di tutte le emozioni pericolose” in classe. Ho detto agli studenti che se avessimo rispettato tali regole quando ero una studente, le discussioni critiche che hanno gettato le basi di così tanta e brillante teoria femminista non avrebbero mai avuto luogo.
L’artista e docente Catherine Lord, nello scrivere di come affrontare il cancro al seno nel suo libro di memorie The Summer of Her Baldness, pone questa domanda: “Perché, mi domando, è snervante piangere davanti a uno studente… Perché piangere in classe, anche se tutti ne abbiamo avuto voglia, sembra essere una minaccia più grave della stupidità, dell’odio o dell’ignoranza?”. Piangere, gemere, disperarsi sono manifestazioni di intensità emotiva temute in classe, perché sconvolgono la gerarchia che ci fa credere che la mente debba sempre avere la meglio sul corpo e sullo spirito. Siamo chiamati ad apprendere al di là dei confini del linguaggio, delle parole – là dove condividiamo una comprensione comune – imparando dai nostri sensi, dai nostri stati d’animo, e scoprendo il loro modo di conoscere. Permettendo alle lacrime di esistere, si manifesta l’insurrezione della conoscenza soggiogata.