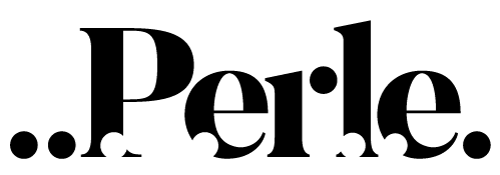Colonialismo Digitale
Postfazione di Ippolita “Colonialismo digitale” per il volume Insegnare a Trasgredire di bell hooks edito per Meltemi editore.
[immagine di copertina: Joe Web]
Colonialismo digitale. Abbiamo scelto di pubblicare questo volume nella nostra collana di libri Culture Radicali perché riteniamo importante contribuire al dibattito attorno alle questioni riguardanti la razza, il genere e la classe attraverso una voce, molto amata ma poco tradotta, capace di partire da una prospettiva critica e libertaria. Tra le molte pubblicazioni di bell hooks abbiamo posto il focus sulla questione della formazione, della pedagogia e della trasmissione dei saperi in un’ottica non solo accademica, ma anche comunitaria.
Il nostro sforzo in questo caso va a sostegno dei e delle Black Italians che popolano in modo significativo le aule scolastiche e a cui, nella maggior parte dei casi, è negato il diritto alla cittadinanza, perché figli di genitori non italiani. Questa compagine giovanile, altamente discriminata, è parte dei movimenti studenteschi e produce movimento a sé, riempiendo le piazze con la propria istanza di lotta contro la razzializzazione e l’oppressione delle persone afro-discendenti, latino-discendenti e “non bianche” o “diversamente bianche”, con riferimento alle migrazioni dall’Asia e dall’Est Europa. Ci auguriamo che al più presto aumenti anche il numero degli insegnanti non bianchi ed è anche a loro che vogliamo dedicare questa pubblicazione, nella certezza che il pensiero di hooks sarà uno strumento importante per affrontare la loro sfida.
Abbiamo scelto di affidare l’introduzione a Rahel Sereke e Mackda Ghebremariam Tesfau’, due attiviste della blackness italiana e femministe intersezionali impegnate nella tutela dei migranti e dei richiedenti asilo, oltre che in esperienze di convivenze inter- e trans-culturali come pratiche di solidarietà politiche e antirazziste. La traduzione è di feminoska, attivista antispecista che si occupa di traduzione militante anche attraverso esperienze collettive.
Con l’occasione vogliamo ringraziare Maria Nadotti, intellettuale femminista che per prima ha portato il lavoro di hooks in Italia curando la raccolta Elogio del margine, pubblicata nel 1998 da Feltrinelli, e tessendo con l’autrice un lavoro di scambio intellettuale che ci ha permesso di conoscere da vicino il pensiero di questa compagna nera e ribelle.
Abbiamo voluto caratterizzare la pubblicazione di hooks che avete tra le mani facendola il più possibile “nostra”, partigiana, materia viva per combattere contro il dominio patriarcale capitalista e suprematista bianco.
Il collettivo Ippolita, oltre a occuparsi della collana Culture Radicali per Meltemi editore, si dedica in modo indipendente alla critica tecnologica e allo studio delle culture digitali. Ci occupiamo cioè di mettere in luce come le tecnologie creino regimi di verità, dunque saperi politicamente orientati, a partire dalla loro progettazione tecnica. Nel corso del tempo la strada ci ha portato in modo spontaneo oltre la pratica autoriale, che per noi è caratterizzata dalla scrittura collettiva, verso l’esperienza altamente contraddittoria e conflittuale dell’insegnamento. E naturalmente questo è un altro dei motivi per cui abbiamo voluto dotarci dei consigli di chi ha fatto dell’educazione una pratica radicale di libertà.
Insegnare a trasgredire la norma tecnocratica è una sfida che non può essere ingaggiata senza l’ausilio della meridiana concettuale di genere-razza-classe. Il modo in cui il mondo ha conosciuto la tecnologia è caratterizzato da una dominante coloniale che è ancora pericolosamente sottovalutata. Le piattaforme sono a tutti gli effetti progetti di stampo coloniale che regolano la comunicazione globale secondo uno schema culturalmente guidato dal capitalismo statunitense. Le tecnologie commerciali si installano nei nostri vissuti con l’idea di esportare la democrazia e rendere il mondo un posto migliore, dando completamente per scontato che la loro idea di civiltà sia qualcosa che dovremmo accogliere come un dono prezioso.
Dunque non si tratta solo di strumenti della comunicazione. Ci troviamo di fronte a una forma di suprematismo ideologico, continuazione di quello patriarcale e bianco, coi mezzi tecnologici. Le grandi major dell’IT sono i nuovi padroni globali che ci indicano dove e come produrre senso, omogenizzando ogni differenza culturale. Risuonano le parole di Audre Lorde:
Gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone. Ci possono permettere di batterlo temporaneamente al suo stesso gioco, ma non ci metteranno mai in condizione di attuare un vero cambiamento. E questo fatto è una minaccia solo per quelle donne che ancora definiscono la casa del padrone come la loro unica fonte di sostegno
I servizi web e le app che usiamo tutti i giorni hanno fatto della diversità una variante del consumo. Nel diversity management esiste una scatola per ogni cosa, purché sia digeribile senza sforzi da parte del mercato. Il dissenso e il pensiero critico sono dunque un’alternativa che non mette in discussione il sistema, ma costituisce un semplice +1 da aggiungere alla lista delle variazioni sinora immagazzinate. In questo modo viene creato un falso senso di egualitarismo, un’orizzontalità reificante in cui ogni differenza sembra avere cittadinanza, perché abbiamo tutt* le stesse interfacce di comunicazione.
Le piattaforme sono descritte in modo mistificatorio come strumenti capaci di colmare le differenze di rappresentazione e offrono una promessa di successo alle minoranze a patto che continuino a partecipare e credano nel sistema. Il consumismo tecnologico è il nuovo volto della cultura del dominio, che “promuove la dipendenza dalla menzogna e dalla negazione”: come sostiene hooks:
quella menzogna assume la forma innocente di molti bianchi, che sostengono che il razzismo non esiste più, che esistono condizioni di uguaglianza sociale che consentono a qualsiasi persona nera che lavori sodo di raggiungere l’autosufficienza economica, dimenticandosi che il capitalismo richiede l’esistenza di una sottoclasse di pluslavoro. […] La crisi contemporanea deriva in parte dall’impossibilità di un accesso significativo alla verità. Agli individui non viene solo raccontata la falsità, ma viene raccontata in modo tale da consentirne una comunicazione più efficace. Quando il consumo culturale collettivo e l’attaccamento a tale disinformazione vanno di pari passo con le menzogne personali vissute dagli individui, la nostra capacità di affrontare la realtà è gravemente intaccata, così come la nostra volontà di intervenire per cambiare circostanze ingiuste.
Gli standard tecnici delle ergonomie cognitive non sono stati abbassati per favorire l’emancipazione o l’inclusione della diversità nel dibattito pubblico, ma per allargare la soglia della propaganda politica. Non bisogna avere difficoltà nell’usare la “tecnologia”, perché si tratta di un prodotto di consumo globale che deve intrattenere chiunque abbia un lobo frontale, a partire dalla culla. Viviamo un’ingiunzione a stare al centro dei riflettori e veniamo addestrati al narcisismo come se fosse l’unico modo di emergere e far sentire la propria voce. Come sostengono le sorelle Aph e Syl Ko nel saggio Afro-ismo. Cultura pop, femminismo e veganismo nero, nato nel solco del movimento Black Lives Matter:
Proprio quando le persone nere cominciavano a seppellire il sogno americano, mettendone giustamente in evidenza il presupposto razzista e neoliberista progettato per perpetuare la privazione dei diritti delle minoranze, sono arrivati gli innovatori, usando i social come defibrillatori digitali per rianimarlo. Lo hanno riconfezionato e lo hanno chiamato Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.
I nostri pensieri vanno per un momento a un amico recentemente scomparso, Benedetto Vecchi, giornalista culturale de Il Manifesto che si è occupato da sempre di tecnologie informatiche. Sarebbe stato certamente incuriosito dalla posizione di queste esperienze Nere sul digitale, la sua intelligenza ci manca molto. Ci auguriamo che altri al suo posto abbiano il desiderio di indagare come le questioni della tecnica stiano cambiando in senso critico, anche in relazione al quadrante concettuale di genere-razza-classe.
All’interno dei corsi universitari che teniamo ci accorgiamo di quanto sia delicato rispondere alla domanda “Qual è la cultura dei social?”. Alla retorica che le piattaforme siano un ripetitore di comunicazione pubblica che “funziona” si aggiunge la difesa della propria zona di comfort, lo psicoaddome che ci nutre di micro scariche dopaminergiche da cui non vogliamo sganciarci. Occorre fatica per riconoscere il dominio coloniale dell’Iphone in una prospettiva di coscientizzazione, perché ciò apre a un lavoro di presa in carico della propria coscienza, nella direzione di un cambiamento concreto. E questo fa molta paura.
L’idea che la teoria e la coscienza siano strettamente legate alle pratiche materiali della metamorfosi e dell’autoguarigione percorre tutta l’opera politica e pedagogica di hooks. Perché non basta dire “lo so, ne sono consapevole”, occorre agire.
Il sogno americano risvegliato dai social è l’utopia liberale della conquista dell’Ovest. Una concezione di occupazione territoriale che procede attraverso l’oppressione sistematica delle minoranze e degli altri viventi. L’egoismo virtuoso dell’uomo bianco col fucile è legato a un’idea di comunità ristretta a forme familistiche ultraidentitarie. Questi bias (polarizzazioni, pregiudizi) sono la base culturale implicita nel sistema tecnico che ci è stato fornito e che avalliamo quotidianamente fingendo che sia “neutro”. Le bolle dei filtri, nelle quali siamo convinti di espandere la nostra capacità comunicativa, sono luoghi in cui incontriamo solo ciò che è simile a noi, ciò che ci piace e che, tendenzialmente, rinforza le idee che già abbiamo. L’alternativa conflittuale è disponibile nel formato cancel culture.
Ma se usciamo dal centro e proviamo a tornare ai margini, come bell hooks ci insegna, le alternative comunitarie esistono. In Italia abbiamo alcune esperienze di eccellenza che occorre conoscere e invitare alla contaminazione queer, femminista e decoloniale. Dal 2001, la comunità di A/I (che sta per autistici.org / inventati.org) lavora sui temi dei diritti digitali da una prospettiva critica e per un’autodifesa digitale individuale e collettiva, offre molti servizi utili a sostituire quelli commerciali e opera sempre nel massimo rispetto della privacy di chi entra a far parte della comunità. Ogni anno, dal 1998, si tiene l’hackmeeting, il raduno delle controculture informatiche italiane, nel corso del quale vengono presentati anche nuovi gruppi e servizi, come cisti.org, un server autogestito di Torino che si è fatto notare durante la quarantena per il Covid-19. Ma ce ne sono anche altri, quali indivia.net di Bologna e tracciabi.li di Brescia… Insomma, l’invito è a essere curiosi e cercare un modo diverso per vivere la tecnologia, possibilmente in senso ecologico.
Le sorelle Ko vanno in questa direzione quando si domandano se non sia giunto il momento di tornare ai margini e rilanciare il nucleo radicale dei nostri progetti:
Le piattaforme social diventano strumenti post-razziali. […] Bisogna dunque chiedersi: esiste un modo migliore di impegnarsi in pratiche di attivismo senza utilizzare le piattaforme capitalistiche dei social media? […] Il fatto che vogliamo smantellare la supremazia bianca ma molti di noi non riescono nemmeno a immaginare di eliminare i profili Facebook e gli account Twitter suggerisce che potremmo esservi più legati di quanto avessimo immaginato.
Ed è proprio bell hooks che le ragazze chiamano in supporto, una boomer il cui consiglio è ancora ferocemente sul pezzo quando dice che il margine, il “fuori” dal centro, è qualcosa di più di un semplice spazio di privazione: è un luogo radicale di resistenza e di lotta, dove coltivare un corpus di teorie e pratiche alternative in cui sviluppare un nostro linguaggio creativamente. Dalla raccolta Elogio del margine, i cui concetti di base sono più volte ripresi in questo volume:
Le nostre vite dipendono dalla nostra capacità di concettualizzare alternative, spesso improvvisando. È compito di una pratica culturale radicale teorizzare su questa esperienza in una prospettiva estetica e critica. Per me questo spazio di apertura radicale è il margine, il bordo, là dove la profondità è assoluta. Trovare casa in questo spazio è difficile, ma necessario.
E allora non bastano l’università e la scuola. Abbiamo bisogno di fare comunità educante a partire dalle pratiche di vita in luoghi ibridi di cui non abbiamo il pieno controllo. L’hacking -il metodo in cui si approccia alla tecnologia modificandola in senso creativo e non conforme alle regole- non è inquadrabile in percorsi di studio ufficiali e titoli di studio riconosciuti. Nelle comunità di hacker si impara attraverso l’autoformazione e la condivisione delle competenze. Non è un caso che questi metodi siano stati sussunti per dare vita all’aberrazione chiamata sharing economy (economia collaborativa). Si tratta di modalità di apprendimento per lo più destrutturate e basate su contesti di affinità, quindi estremamente liquide e adattive, che hanno a che fare con il tempo improduttivo e libero dell’ozio. Questo tipo di apprendimento è molto efficace, dimostra come l’inoperosità possa coincidere con la liberazione di energia creativa. Tale tratto anti-autoritario dell’hacking permette una disattivazione dei dispositivi di potere aprendoli a un “nuovo uso” che non era stato previsto: un uso artistico o politico che non risponde necessariamente a una logica strumentale o di vantaggio. Imparare significa “impoterarsi”, sviluppare potentia, certo, ma anche potestas, cioè comprendere la possibilità di esercitare dominio sugli altri e la responsabilità che ne deriva. Il sapere è potere. Questo momento etico, che è molto netto nell’ambito informatico, può avere una sua fioritura politica se messo in relazione a una diversa idea di giustizia sociale che diserti il privilegio maschile e bianco. L’obiettivo è meticciare un insieme vasto di studi e pratiche decoloniali per svincolarli dalla valutazione di chi struttura il potere con l’intento di mantenerci in posizione di subalternità. Sia in ambito universitario, sia nei social network. Questa per noi è la pedagogia hacker. Vogliamo costruire indipendenza e autonomia e accogliere le persone che vengono sistematicamente escluse dai circuiti scolastici.
“Il potere di questo non risiede semplicemente nella possibilità di resistenza alla supremazia bianca, ma nella creazione di uno spazio per la produzione di culture ed epistemologie alternative, modi di pensare e conoscere differenti e cruciali al fine di creare una visione controegemonica del mondo”
Così hooks ci esorta a costruire uno spazio di saperi esterno a quelli ufficialmente preposti al compito. Non stiamo dicendo che non si debba mettere alla prova la nostra capacità di contaminare i contesti istituzionali: continueremo a “insegnare a trasgredire” nella scuola e nell’università. Stiamo dicendo che non dobbiamo dimenticarci chi siamo (attivist*) e da dove veniamo (dal basso). Gli spazi autogestiti possono essere palestre della democrazia diretta e incubatrici di avanguardie culturali con lo sguardo puntato su transfemminismo e blackness. Mobilitare archivi, case editrici, autoproduzioni, traduzioni militanti è una ricetta che funziona e alla quale non dovremmo rinunciare.
Il compito pedagogico che hooks ci assegna è alimentare una cultura comune fatta di pratiche di vita orientate alla cura e all’autoguarigione e che ci tengano in allenamento nella capacità di articolare creativamente il conflitto. Una variante femminista e nera dell’epimèleia heautoù che a noi piace chiamare hacking del sé. Impariamo ad alzare il livello:
“Quando la nostra esperienza vissuta della teoria critica è fondamentalmente legata a processi di autoguarigione e di liberazione collettiva, non esiste alcun divario tra teoria e pratica”.
Ecco che la filosofia torna a essere una pratica di vita.
Chiudiamo con un invito all’azione diretta, dal saggio di Rachele Borghi, professora della Sorbona e attivista transfemminista, Decolonialità e Privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema mondo:
La combinazione degli ingredienti della modernità – capitalismo, colonialismo, sapere, rapporti di dominazione – ha permesso di preparare la torta chiamata civiltà, il tutto cotto nel forno della colonialità. Il loro legante è stato il razzismo. Dal 1492, ciò che ha creato il sistema-mondo è stata l’occupazione di territori, legittimata dalla gerarchizzazione delle persone su base razziale e dall’idea che ci fosse una missione civilizzatrice. Decolonializzare il sistema-mondo necessita di distruggere la civiltà. Perché il concetto di civiltà si basa su una costruzione epistemologica che, di fatto, giustifica e legittima la violenza che la civiltà produce. […] Pensare decolonialmente un mondo pluriversale significa immaginarlo come un arcipelago di punti di enunciazione, una costellazione di micropolitiche di decolonialità, di laboratori di sperimentazione, a partire dal proprio posizionamento e dai propri privilegi. Non è solo una questione di punti di vista, è piuttosto una questione di punti di azione.