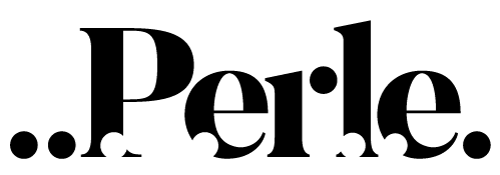Un filo è un corpo sottile
Un estratto dal volume di Laura Fontanella, Perdere il filo. Esperienze collettive di traduzione transfemminista, Meltemi 2024, Collana Culture radicali curata dal gruppo di ricerca Ippolita.
Un filo è un corpo lungo, sottile, spesso avvolto su sé sesso, in una matassa. Si tratta di un oggetto semplice, di valenza quotidiana. Eppure, dietro a questo oggetto così ordinario, e per certi versi persino banale, si nasconde una fitta trama di sensi, di significati e di simboli.
Un filo può essere composto da diversi materiali; può essere di seta, di cotone, di spago. Tuttavia, per estensione, usiamo questa parola per indicare qualsiasi cosa disponga di un corpo affusolato e sottile, un filo d’erba o di paglia, o per indicare qualcosa di tenue, un filo di vento, un filo di luce, un filo di voce. Al femminile plurale, questa straordinaria e minuscola parola, densa quanto un universo in miniatura, si usa per parlare delle fila di una trama, di un ordito, di una storia.
Quando si vuole sottolineare la continuità di un ragionamento, allora si parla invece del filo delle idee, della propria o dell’altrui riflessione. Tant’è che il filo è anche quello della tradizione: una lunga catena, o forse dovremmo chiamarla spirale, di usanze, di norme, di sedimentazioni capaci di ripetersi, e riprodursi all’infinito.
Quando il filo si associa a un verbo, come in stare in fila o mettersi in fila, ecco che il filo comincia a somigliare più a un cappio, a una limitazione, a un’imposizione d’ordine, a un disciplinamento: bisogna posizionarsi on a straight line, rigare dritto, aderire al pensiero straight1: se così si fa, andrà tutto per il verso giusto. Per fortuna, casomai il cappio stringesse troppo, possiamo sempre dare del filo da torcere a chi ce l’ha messo al collo, ostacolando il sistema mondo2 con ogni mezzo necessario.
E se neanche questo bastasse, possiamo affidarci al filo della nostra schiena, a quel bridge called my back3, alla nostra spina dorsale che può farsi ponte, creando una linea continua tra un corpo e un altro, connessioni inedite sulla base della propria esperienza, del proprio vissuto.
Simbolicamente, ogni filo rappresenta una frase, sia essa pronunciata, letta, scritta oppure tradotta. Come perle su un filo, le parole imbastiscono una collana, si dispongono in un discorso. Basta poco perché ci sfuggano di mano in un’esplosione alabastrina.
Non a caso, l’espressione perdere il filo si riferisce a una distrazione, a una disattenzione, a una mancanza tale per cui il soggetto parlante smarrisce ogni logicità, ogni sensatezza, e quindi, inevitabilmente, ogni credibilità. Quando il filo cede, si rompe, o viene perduto in altra maniera, della solidità di quel discorso si dice rimanga poco o niente: un balbettio, un vaneggiamento, un delirio.
Nell’ambito della cultura occidentale, che ha fatto della scientificità e del rigore scientifico il suo emblema, è perciò importante non perdere mai quel filo, né tirar(n)e troppo la corda.
Per la società occidentale è, al contrario, di fondamentale importanza dimostrare di avere una padronanza pressoché assoluta dell’arte della retorica e della dialettica; è necessario disporre d’una lucidità estrema; è necessario costruire i propri discorsi affinché risultino impeccabili, caratterizzati da un impenetrabile scrupolosità, nascondendo ogni fragilità, ogni dubbio, ogni incertezza dietro le solide e invalicabili mura della coerenza. Nell’ambito della cultura occidentale, perdere il filo del discorso genera stigma sociale, genera mostri.
La persona che perde il filo del discorso viene isolata, spinta al margine, zittita, silenziata affinché non contamini altri individui con le sue insensatezze, con le sue digressioni, con le sue espressioni inconsuete, singolari, visionarie, rappresentanti quell’alterità da sempre condannata al silenzio. La persona che perde il filo del discorso deve essere allontanata, prima che sia troppo tardi. Prima che altri individui apprendano la sua lingua distorta, il suo schema intricato, facendolo proprio.
La persona che perde il filo del discorso non è utile al sistema capitalista: non sa ragionare nel modo predisposto, e soprattutto finisce col porsi e col porre domande scomode, che non hanno risposte chiare ma che generano altre domande ancora, in un loop che va a minare proprio quel rigore scientifico che tanto è fondamentale; non sa parlare seguendo il codice che le è stato ordinato di usare, non riesce a riprodurre quel modo di esprimersi; spicca, anche quando vorrebbe non farlo, anche quando preferirebbe appiattirsi fino a scomparire, amalgamandosi con il resto della società; questa persona è vista come incapace, non sa neppure produrre in un mondo che in cui la produttività è tutto, e che ha vincolato ad essa il nostro diritto all’esistenza: si perde nel labirinto del Minotauro anziché uscirne baldanzosa e trionfante. Smarrendosi di continuo, si rende inaffidabile: cessa di essere utile per un sistema che la vorrebbe rendere ingranaggio perfetto e funzionante. È un’anomalia.
Il filo del discorso, sebbene sia metafora intangibile, genera oppressioni materiali, che invadono la vita di tutti i giorni. Il non riuscire a trattenerlo, il lasciarselo sfuggire, o addirittura l’atto ribelle del rifiutarlo comporta conseguenze concrete che impattano sulla qualità della nostra esistenza. Eppure, in piena contraddizione, questo filo imperdibile non è altro che un’illusione, una sovrastruttura millenaria, una storia persuasiva che ci viene costantemente ripetuta nella speranza che, per sfinimento, ci porti alla resa.
Il filo del discorso non deve andar mai perduto poiché è carico di significati, impregnato di potere fin nelle sue radici di stoffa. Il filo del discorso va saldamente tenuto, e solo stringendolo fino a far sanguinare i palmi, (forse) andrà tutto bene. Il filo del discorso, stretto in pugno come le redini di un cocchio, dovrebbe condurci verso il successo, verso il sogno di una strada spianata; dovrebbe farsi ancora di salvezza, fornendoci quella stabilità che altrimenti mai avremmo. Il filo del discorso rappresenta un destino già scritto, una consequenzialità predeterminata, una tradizione preposta e le aspettative da soddisfare.
Sottrarsi alla stretta di questo filo non è tuttavia impresa facile. Innanzitutto, quel filo sottile e resistente, come fosse nylon, deve essere notato. Spesso si mimetizza sullo sfondo, sfugge all’occhio nel tentativo di sembrare “naturale”, e quindi “neutro”. Si rende invisibile, irrintracciabile: dobbiamo nutrire un genuino sospetto per tutto quello che sembra naturale e chiederci sempre “chi lo ha reso tale?” e “per quale ragione?”.
Quando cominci a notare il filo, a vedere la sua maglia stringersi attorno a qualsiasi cosa, in modo capillare, è allora che apri gli occhi, come se vedessi il mondo per la prima volta nella sua spaventosa coerenza: è allora che “impari che niente è più pericoloso del dato per scontato, del taken for granted. Dare una cosa per scontata significa concederle un potere immenso dato che questa operazione comporta la sua interiorizzazione, la sua naturalizzazione e soprattutto la possibilità di non mettere più quella cosa in discussione.”4
Eppure, l’atto e il processo stesso del perdere il filo, è un tema che, in tutte le sue accezioni e declinazioni simboliche, si verifica nel quotidiano, sia sul piano del reale, sia sul piano testuale e letterario. Trova declinazioni tutt’intorno a noi.
Nell’intramontabile romanzo di James Baldwin, La Stanza di Giovanni, David, il giovane protagonista, decide di recarsi a Parigi sperando che un periodo lontano da casa possa aiutarlo a riflettere con maggiore lucidità sui propri desideri, a far luce sul proprio futuro, a comprendere la propria identità. David, che parte alla volta dellla capitale francese avendo avuto un’esperienza omosessuale qualche anno prima, intende (ri)trovare sé stesso, riprendere il filo dell’eterosessualità che da tempo teme gli stia sfuggendo. Darsi una calmata, tornare sulla retta via. Tornare a essere in place, e non più out of place.
Vuole tornare ad aderire ai dettami dell’eterosessualità, a quel modello di maschilità patriarcale che gli deriva dal suo stesso padre. David vuole azzerare le sue esperienze passate, cancellarle, tornare a quando tutto era più facile. Vorrebbe non aver mai perso quel filo, non aver mai mollato la presa. Eppure, David sa bene quanto non si possa tornare indietro. Tradire la propria identità, e farlo tutti i giorni della propria vita, di fatto, è molto più difficile: “Forse, come diciamo in America, volevo trovare me stesso […] il che tradisce il preoccupante sospetto che qualcosa sia finito nel posto sbagliato”5.
In questo straordinario romanzo, è proprio questa disperata ricerca del filo perduto a condurre David fuori rotta. Il giovane è certo che qualcosa sia cambiato per sempre, e ne è ancora più certo quando, appunto, incontra Giovanni. David lotta contro sé stesso: è cosciente, sebbene stenti ad ammetterlo, che alla rinuncia dell’eterosessualità corrisponda lo smantellamento delle promesse patriarcali, e dei privilegi di cui poteva godere come uomo americano, bianco e sposato, marito della giovane Hella. Solo alla fine del romanzo David si concederà di perdere il filo, quand’ecco che però sarà troppo tardi. Riecheggiano infine come fossero un monito, le parole del suo amico Jacques: “Vieni fuori, vieni fuori” gli dirà l’amico Jacques con veemenza “ovunque tu sia!”6.
Nel romanzo di Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, Janina Duszejko perde il filo continuamente e pertanto la sua figura all’interno della comunità montana di cui è parte, viene costantemente screditata. Janina è un’insegnante di inglese, che ama le poesie di William Blake, l’oroscopo e gli Animali. Non tollera venga mossa alcuna violenza contro di loro e questo, in un contesto montano in cui la caccia e il bracconaggio sono all’ordine del giorno, la porrà spesso al centro di circostanze di difficile gestione.
Sebbene Janina si rivolga alle forze dell’ordine locali, denunciando soprusi e violenze mosse ai danni degli Animali, non ottiene da loro né alcun riscontro positivo, né la benché minima attenzione, ma solo il loro perpetuo scherno. Se a questo aggiungiamo anche un suo posizionamento profondamente anticlericale, che si traduce in un’allergia all’ipocrisia della chiesa e ai discorsi del parroco, ecco che Janina viene subito inserita all’interno dello stereotipo della “vecchia pazza del villaggio”, una sconclusionata i cui discorsi non hanno alcun senso, talmente lontani dal pensiero dominante da risultare ridicoli: “Vorrei conoscere la scrittura degli Animali”, dice Janice al poliziotto che, tra uno sbuffo e l’altro, decide di redigere un rapporto, tanto per levarsela dai piedi “i segni con cui si possano scrivere degli avvertimenti per loro: Non avvicinatevi, quel cibo porta alla morte. State alla larga dai pulpiti, da lì non vi predicheranno nessun vangelo, non otterrete le buone parole, non vi prometteranno la redenzione dopo la morte, non avranno misericordia della vostra povera anima, perché non avete un’anima. Non vedranno in voi il loro prossimo, non vi benediranno. L’anima ce l’ha il più abietto dei criminali, ma non tu, bellissima Cerva, e neanche tu, Cinghiale, e neanche tu, Anitra selvatica, né tu, Maiale, né tu, Cane. Oramai l’assassinio è impunito. E poiché è impunito, nessuno lo nota più. E poiché nessuno lo nota più, non esiste”7.
Chi perde il filo, finisce con l’esporsi, con il mettersi allo scoperto, con l’occupare una posizione di vulnerabilità8. Si rende visibile, fuoriesce dai ranghi, libera la propria voce, alza la testa. Eppure, è proprio da questa posizione che, chi perde il filo, può finalmente vedere le cose da una prospettiva differente. Chi perde il filo apre a nuove possibilità: diventa apripista, lasciandosi contaminare dall’ignoto.
Gloria Anzaldúa fa del perdere il filo del discorso uno stile di vita e di scrittura. In Terre di Confine, La Frontera. La nuova mestiza, intreccia prosa a poesia, lingue e registri diversi, miscelando sostanze apparentemente diverse, creando matasse e trame che sfuggono alle convenzioni letterarie e linguistiche; mescola quel che tocca, generando un testo ammaliante e capace di scardinare gli stilemi occidentali e coloniali, assottigliando i confini in un atto estremamente politico di ribellione. Il filo del discorso per Anzaldúa è tutto fuorché una linea retta, un confine netto; al contrario, è luogo conflittuale, politico, di sopravvivenza, di lotta. Il suo discorso è fluido, polifonico, e come la pelle della terra, non conosce cuciture, non si fa imbrigliare da dei confini: “perché io, una mestiza non faccio che uscire da una cultura ed entrare in un’altra, perché io sono in tutte le culture allo stesso tempo, alma entre dos mundos, tres, cuatro, me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente9”. Il filo spinato, scrive Anzaldúa, è la sua casa10.
bell hooks, in Elogio del margine. Scrivere al buio11, analogamente, si lascia alle spalle il filo del discorso proposto dalla società patriarcale, bianca, eterosessuale e capitalista, non solo venendo dal margine, ma ponendo il margine stesso come luogo di lotta politica, come spazio da cui costruire la propria critica al sistema di dominio. La sua critica passa attraverso l’autocoscienza femminista, ossia la creazione di spazi in cui partire da sé, fondati sulla mutua fiducia, in cui confrontarsi in merito alle proprie oppressioni materiali, in cui dibattere alla ricerca di soluzioni personali e politiche12.
L’autocoscienza di bell hooks, così come quella di cui hanno parlato altre femministe in altre regioni del mondo occidentale, è stata a lungo considerata come una pratica muliebre di poco conto, non diversa dal confidarsi, dal lamentarsi degli uomini e dal fare dell’ironia sui loro comportamenti sessuali13. Vista da fuori, l’autocoscienza deve essere apparsa a molte persone come una pratica inutile, distraente rispetto alle vere questioni, alle vere urgenze movimentistiche. Perché starsene a parlare quando ci sono delle cose ben più concrete di cui occuparsi?
Il sessismo, tra la fine degli anni 60’ e l’inizio degli anni 70’ screditò le potenzialità dell’autocoscienza. Screditò la possibilità di raccontarsi, di partire dal proprio vissuto, l’occasione di riconoscere il proprio e l’altrui posizionamento, di divagare, di perdere il filo insieme, collettivamente. Il filo del discorso, nella società eterosessuale, cisgender, patriarcale, bianca, abile e borghese sembra sempre dover avere uno scopo fattuale, produttivo. Eppure, seppur ancor oggi possa apparire come inutile divagazione, chi ha attraversato spazi politici, collettivi, di costruzione di transorellanze sa bene quanto sia importante conoscersi intimamente per costruire qualsiasi elaborazione, per fare alcuni discorsi e per smantellarne altri. Non rischia di perdere il filo chi non apre bocca, chi non si pronuncia mai. Perdere il filo, al contrario, è tipico di chi parla, di chi ragiona, di chi costruisce, di chi si esprime, di chi usa la propria voce per dare forma al proprio pensiero critico. Perdere il filo, potremmo dire, è tipico di chi prende parola, con emozione, talvolta tremante di rabbia.
Chi perde il filo del discorso in un’assemblea pubblica, stringendo il microfono o il megafono durante un corteo, chi perde il filo del discorso in una riunione collettiva, non teme il silenzio perché sa che quel silenzio è denso di significato. Coltiva la propria libertà, rivendica il proprio smarrimento.
Chi perde il filo del discorso, a volte, smarrisce le parole. In altri casi, si rende conto che quelle parole che va cercando, non esistono affatto. Semplicemente non esistono e, pertanto, non possono descrivere l’immagine che la persona ha in mente. Altre volte, quelle parole, sono state invece rimosse, o infangate. Quando perdiamo il filo del discorso, e ci troviamo di fronte all’angoscia di una mancanza, di una perdita, di un’omissione, non possiamo non pensare al perché, laddove lo spazio dovrebbe essere pieno, ci sia, al contrario, uno spazio vuoto. Perdere il filo del discorso genera domande; ci pone di fronte alla necessità di comprendere su che base effettuiamo le nostre quotidiane scelte linguistiche, ci pone di fronte al bisogno di capire perché selezioniamo alcune parole mentre ne scartiamo altre. Perdere il filo ci consente di esplorare un silenzio gonfio, generativo, di portare a galla questioni che riguardano il modo in cui parliamo, scriviamo, traduciamo.
Nel fumetto di Linnea Sterte, Stages of Rot, tradotto in italiano come Disfacimento, ci troviamo di fronte “all’afasia commossa di non sapere come chiamare qualcosa”14. In Disfacimento, specie diverse si incontrano, si confrontano, si parlano, scoprendo di parlare la stessa lingua solo apparentemente. Si conoscono le parole, ma non i loro significati, non quel che vi soggiace: “Perchè hai questa forma, quella di una donna?” domanda una figura umana all’altra. “Cosa significa?”, incalza l’uomo. “Oh, non saprei” risponde la creatura aliena dal corpo di donna, prima di librarsi in volo. Le poche parole di questo fumetto ci fanno spesso incespicare: le comprendiamo e non le comprendiamo appieno. Ne cogliamo la superficie, ma ci sfuggono appena la nostra mano rompe la tensione sul filo dell’acqua.
“Le tavole di disfacimento contengono poche parole, ma è stato difficile tradurle perché appartengono a una lingua segreta, falsamente semplice, geneticamente aliena e inattingibile”15. Sebbene il testo sia tradotto in italiano, che lingua parlano davvero i personaggi del fumetto? In che modo si esprimono? E casomai dovessero incontrarsi, faccia a faccia, specie a specie, come faranno a tradursi? Quali scelte compiranno? .
Sebbene in questa società perdere il filo del discorso, sia sul piano più concreto che simbolico, costituisca motivo di biasimo, corrisponda a una perdita, e generi oppressioni o sanzioni, rimango affascinata dall’energia che si sprigiona dietro questa semplice espressione quotidiana. Mi sembra che produca, proprio come il fumetto di Linnea Sterte, un “sottrarsi per rinascere altrove”16.
Per tutte queste ragioni, Perdere il Filo è anche il titolo che ho scelto per questo volume che parla di traduzione, di esperienze collettive, di pratiche transfemministe, di percorsi volti alla decolonialità e all’intersezionalità. Per diverso tempo, ho cercato un’espressione che fosse così evocativa, che richiamasse quell’intima connessione che c’è tra il sé, il testo scritto, quello tradotto, e il proprio posizionamento nel mondo. In Perdere il Filo, dunque, si parla di tutti questi argomenti, divagando forse, come ho fatto in questa introduzione.
Nella fattispecie, racconterò di un’esperienza laboratoriale che, ormai, percorro da diversi anni, di una situazione politica che reputo generativa, sorprendente, che più volte mi ha lasciata a bocca aperta, senza parole, che ha smosso dentro di me più domande di quante ne potessi talvolta contenere, senza concedermi giustamente la soddisfazione di risposte semplici e immediate.
Con questo volume vorrei raccontare dell’esperienza politica del laboratorio Gender in Translation. Spero che tra queste pagine, ogni leggente possa perdere il filo a sua volta, lasciandosi contaminare dalle domande, indagando quel silenzio parlante che sta ai margini del discorso dominante, andando per dedali, per con-fluenze, per crocicchi, in dis-ordine, attraversando soglie. Per parlare di questo laboratorio, che deve il suo nome a un importante testo di Sherry Simons che venne pubblicato da Routledge nel 1996 e che rivoluzionò il mondo della traduzione17, ho voluto sfruttare media diversi, entrando in una babele di stimoli, di significati, di riferimenti, provando a rompere con quella tradizione che vuole che tutti questi saperi rimangano separati in compartimenti stagni.
Questo volume non è un manuale di traduzione; vuole essere più un compendio, un grimorio. Queste pagine non hanno lo scopo di imporre alcun modo presumibilmente corretto di tradurre o di organizzare laboratori incentrati sulla traduzione ma, al contrario, hanno lo scopo di raccontare esperienze vissute in traduzione, mostrare altre possibilità, approcci alternativi al testo, e forse al mondo. Questo libro vuole mettere in risalto il valore aggiunto che deriva da una pluralità di proposte, di sguardi; sottolineare quanto la traduzione possa essere uno strumento per aprire gli occhi su di sé e sulle dinamiche del sistema mondo, cambiandoci irrimediabilmente, per sempre. Spero che tra le sue pagine si possano trovare spunti, suggerimenti, nuovi desideri, e qualche ispirazione. Spero che chi lo leggerà non avrà più bisogno di fili, impalcature e sovrastrutture a cui aggrapparsi; spero che chi lo leggerà possa abbracciare il cambiamento profondo che ogni traduzione provoca, così come il suo potere rivoluzionario.
Continua la lettura di Galindo sul tema del lavoro sessuale sul volume Femminismo Bastardo, Mimesis edizioni.

1 Monique Wittig, Il Pensiero Eterosessuale, traduzione e curatela di Federico Zappino, Ombre Corte, 2019.
2 Rachele Borghi, Decolonialità e Privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema mondo, edito da Meltemi, 2020.
3 Cherrie L. Moraga, Gloria E. Anzaldua, This Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Color, con una prefazione di Cade Bambara, Persephone Press, 1981.
4 Rachele Borghi, Decolonialità e Privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema mondo, Meltemi, 2020, p.45.
5 James Baldwin, La Stanza di Giovanni, traduzione di Alessandro Clericurzio, Fandango, 2024, p.32.
6 ibidem, p.74.
7 Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, traduzione di Silvano de Fanti, Bompiani, 2020, p.104.
8 Stacy Alaimo, Allo scoperto. Politiche e piaceri ambientali in tempi postumani, traduzione Laura Fontanella, curatela Angela Balzano, Mimesis, 2024.
9 Gloria Anzaldúa, Terre di Confine, La Frontera. La nuova mestiza, traduzione di Paola Zaccaria, Black Coffee Edizioni, 2022, p.21.
10 Gloria Anzaldúa, Terre di Confine, La Frontera. La nuova mestiza, traduzione di Paola Zaccaria, Black Coffee Edizioni, 2022, p.106.
11 Cinzia Arruzza, Lidia Cirillo, Storia delle storie del femminismo, Alegre, 2017, pp.14-15.
12 bell hooks, Il femminismo è per tutti. Una politica appassionata, traduzione di Maria Nadotti, Tamu Edizioni, 2021, pp.40-41.
13 bell hooks, Elogio del margine. Scrivere al Buio, traduzione e curatela di Maria Nadotti, 2020, Tamu Edizioni.
14 Linnea Sterte, Disfacimento, traduzione di Claudia Durastanti, add Editore, 2022.
15 Ibidem, postfazione al testo.
16 Ibidem, postazione al testo.
17 Sherry Simons, Gender in Translation, Routledge, 1996.