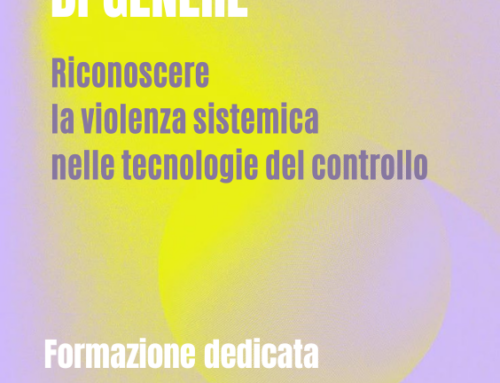La prefazione di Ippolita al libro Materialismo Radicale di Rosi Braidotti
Il movimento femminista, transfemminista e queer che negli ultimi anni ha dato vita al dibattito politico e alle mobilitazioni che hanno invaso le piazze internazionali ha il compito cruciale di interrogarsi attorno ai temi delle nuove scienze e tecnologie. Il compito non è semplice perché, il capitalismo assume “oggi le sembianze di un postantropocentrismo a vantaggio delle forze di mercato che impunemente privatizzano la vita stessa”. Camuffamento marcato sui temi delle tecnologie riproduttive come la surrogazione di gravidanza e nella narrazione degli interventi biotecnologici su animali, semi, cellule e piante.
Con Braidotti condividiamo dunque l’urgenza di elaborare nuovi riposizionamenti critici che non richiamino a una concezione unitaria del soggetto, ma che siano capaci di stabilire alleanze transindividuali, antispeciste, ecologiste e tecnologiche. Per quanto riguarda gli studi che abbiamo dedicato all’informatica, e in particolare riguardo alle piattaforme anarcocapitaliste e ai social media commerciali che annoveriamo, sulla scorta di Donna Haraway, tra le tecnologie del dominio, rileviamo una narrazione che si fa sempre più transumanista. Corpo e mente vengono concepiti come povere versioni organiche di una macchina potenzialmente perfetta.
I transumanisti inseguono il sogno dell’immortalità tecnologica, dove la mente potrà essere travasata in un corpo “altro” non soggetto a consunzione: nomi nuovi per vecchi dispotismi. Questa critica non vuole riprendere una visione sacrale della natura (o desacralizzarla, riproponendo allo stesso modo uno dei tanti vuoti universalismi del pensiero), ma problematizzare la questione del limite e dell’interdipendenza per rendere i processi di trasformazione autonomi e sostenibili. Così come il corpo improduttivo è inutile in ottica capitalista, altrettanto lo è concepirlo come perfettibile all’infinito, analisi manchevole delle nuove soglie (e soggettività) generate dai meticciamenti con il mondo informatico, rimanda ad un contesto in cui performance ed efficacia sono campione di riferimento, ideologie iscritte nella mutazione stessa. Pura ideologia della tecnica, dove la tecnica è il proprio fine, in cui gli assetti sociali e i rapporti di produzione non vengono messi in discussione, pur rinnovandosi in molte versioni, sempre diverse: versioni animali, versioni dai generi sessuali imprevisti, versioni razzializzate, versioni da consumare come prodotti commerciali. Riflettere criticamente sulle mutazioni e le relazioni con i dispositivi tecnologici, riconoscendone la soggettività e la parzialità, mette al riparo da forme di delega totale in cui la tecnologia – alla stregua dell’escatologia cristiana – è concepita come apparato di salvazione; dall’estinzione, dalle ingiustizie sociali, dalle condizioni di sfruttamento.
La discussione sul transumanismo può sembrare peregrina al di fuori delle conventicole tecnofile californiane, e del tutto fuori luogo per la stragrande maggioranza degli esseri umani e non umani che cerca faticosamente di sopravvivere, e ha il problema quotidiano di accedere all’acqua potabile e a una quantità sufficiente di cibo, non di accedere all’immortalità tecnologica. Ma il transumanismo, primo cugino dell’ideologia anarcocapitalista che abbiamo approfondito nei nostri scritti, contribuisce a reintrodurre l’utopia nel pensiero liberale e per questa ragione non va sottovalutato. Le esperienze del transfemminismo non vanno in alcun modo confuse con la propaganda transumanista che vede l’esperienza organica e la morte come un bug da fixare. A questa narrazione tossica dobbiamo opporre un lavoro di hacking del sé, attraverso una ricombinazione radicale, cioè disidentificandoci e disumanizzandoci, ponendo al centro non l’identità, ma la relazione, l’interdipendenza. Qualcuno dice “dobbiamo imparare ad abitare la catastrofe”, ma non è forse la catastrofe una condizione esistenziale? La tragedia della morte, lo scandalo dell’esistenza degli altri, la parzialità dello sguardo che non vede se stesso. Forse il baratro è un punto di vista della fragilità dal quale possiamo finalmente parlare e agire con coscienza (eliminando il senso di colpa) anche delle catastrofi ambientali e politiche nelle quali già abitiamo. La finitudine mortale, il rapporto con il limite sia delle risorse computazionali macchiniche che di quelle biologiche ed emotive dei corpi, diventa una sfida a usare creativamente la nostra intelligenza. Abitare le soglie, crearne una varietà, in modo che i limiti non si irrigidiscano diventando confini invalicabili, ma siano invece negoziabili, anche in termini di senso. Fare politica significa cimentarsi in un’etica delle soglie. Per noi questo vale per tutte le esperienze di attraversamento, siano tecnologiche, di genere sessuale o di frontiere tra una costa del mediterraneo a un’altra. Vale anche per la rete: Gmail oramai funziona sui dispositivi Android come un permesso di soggiorno: se ne sei sprovvisto non puoi entrare. L’email è lo strumento attraverso cui ci autentichiamo, ciò che garantisce attraverso una log-in e password che “noi siamo veramente noi” e che letteralmente ci fa accedere a noi stessi, cioè a quella parte di noi digitale che consideriamo sempre più importante, ma che è sita in un altrove; questa soglia tra l’interiorità e l’esterno è in comproprietà con i fornitori dei servizi. Vogliamo negoziare questa soglia a partire dal “baratro” emotivo che la confort zone capitalistica ha generato in noi?
La mente è coestensiva al corpo e il corpo è coestensivo alla mente. E questi sono sempre in divenire metamorfico per mano delle relazioni nelle quali siamo immersi. L’esperienza digitale, individuale e di massa al contempo, non è affatto disincarnata, è tanto psichica quanto fisica, dunque coinvolge concretamente l’intero apparato somato-psichico. Quando interagiamo collettivamente nei media di massa, stiamo interagendo anche con una struttura rigidamente normativa che ha lo scopo di estrarre dati dalla nostra esperienza di reciprocità, ma non lasciamo a casa nulla, siamo interamente coinvolti, anche se nel frattempo stiamo cucinando o prendendo la metropolitana. Siamo insieme e da sole allo stesso tempo, fuori e dentro noi stessi, fuori e dentro il recinto della piattaforma panottica.
L’esperienza dei social, e delle altre piattaforme del consumismo intersoggettivo, per quanto sia una dispotica riduzione della complessità delle relazioni, rende bene evidente, in tutta la sua materialità, la dipendenza tra psiche e soma.
Il profilo che utilizziamo quando siamo loggati sulla piattaforma, è in grado di reagire trasduttivamente sia come sensazione (fisica) che come percezione (elaborazione psichica di senso): il like ricevuto va a toccare (come una carezza) e a significare (come un complimento). Carezza e complimento sono “travestite” da informazioni, nel senso che hanno in effetti anche lo statuto di informazioni. In questo modo possiamo formalmente immagazzinare molte “informazioni” con la sensazione di aver ricevuto molte carezze ed elogi. Dunque ci sentiamo al contempo più apprezzati e più “informati”. Atto estremo di formazione che il dispositivo compie sull’utente, addestrandola progressivamente a una sempre più efficiente performatività funzionale. Esperienza ubiqua e satura di fusionalità spaziale e intersoggettiva che codifica e cattura una complessità che esiste anche nella vita analogica, ma nell’architettura panottica può essere igienizzata , disciplinata e messa in produzione.
Si palesa anche la materialità del divenire molteplice del soggetto e lo sconfinamento tra il sé e la comunità, dove le due identità si co-costruiscono reciprocamente in una serie di raddoppiamenti e biforcazioni. Il primo è lo sdoppiamento dell’utente rispetto al proprio profilo, cioè del soggetto nei confronti di se stesso: quando entriamo in un profilo, letteralmente, stiamo accedendo a noi stessi. L’accesso implica il riconoscimento e l’autenticazione da parte di un’autorità terza: dobbiamo dimostrare di essere noi stesse ricordando il nostro nome (login) e la nostra parola d’ordine (password); se sbagliamo, dobbiamo produrre altre prove a sostegno della nostra identità: risposte a domande segrete, numeri di cellulare, o cose obsolete come i fax… tutto per entrare nel nostro alter ego che vive in un luogo militarizzato, in casa d’altri, dove vigono le regole d’altri, quelle scritte nei Termini di Servizio che (quasi) mai vengono letti. Accediamo alle nostre memorie, ma anche al nostro presente, a ciò che è accaduto mentre eravamo “fuori di noi”, disconnessi, e anche alla programmazione del nostro futuro.
Il secondo sdoppiamento riguarda le dinamiche relazionali che creano gruppi, collettività, partecipazione. Si tratta di una sorta di individuazione psichica collettiva, il prodotto cioè della relazione consustanziale che abbiamo con noi stessi e con la comunità. Questa particolare dipendenza operativa tra il sé e gli altri, che pone al centro non l’essere umano ma la relazione, è parte del dibattito attuale sia in campo biologico che filosofico e i femminismi ne sono pienamente coinvolti, a partire dalla riflessione sulla simbiogenesi fino all’olobioma di Donna Haraway e della riflessione di Rosi Braidotti sul senso e i modi dell’operatività etica, che attraversa l’interezza della sua opera.
A questo proposito risulta centrale anche l’analisi meno praticata e altrettanto incisiva descritta come transindividuale dall’opera già citata di Gilbert Simondon, L’individuazione psichica collettiva. Si tratta di una tensione che forma e supera gli individui prolungandoli sia nel campo dell’identità personale che in quello della condivisione collettiva, una categoria che possiede una logica propria, una dimensione ricorsiva che lavora e modifica continuamente la sua stessa origine. Il transindividuale non è un mero rapporto funzionale, sia perché concilia, fino al parossismo, l’unità tra azione ed emozione, sia perché esercita una coscienza riflessiva, cioè introduce norme ratte dal comportamento, nel comportamento stesso. È difficile intendere questo processo se non si accetta l’idea, elaborata nel solco della cibernetica, di una reciproca convertibilità delle strutture in operazioni e delle operazioni in strutture. Abbiamo la relazione tra l’utente e se stesso, relazione ulteriormente duplice perché si svolge sia nel medium digitale che nella realtà analogica. Ma abbiamo la relazione del soggetto-utente con il collettivo-massa, anch’essa sdoppiata nelle categorie di analogica e digitale. Tra tutte queste “relazioni di relazioni” il web funziona come un trasduttore, cioè trasmette energia-informazione modificandola in base al punto di atterraggio somato-psichico a cui arriva.
I servizi tecnologici con i quali siamo alle prese quotidianamente sono più complessi di quanto non vogliano dare a vedere, sono costituiti per la maggior parte da bacini separati dalle Rete di Internet che hanno come base lo spazio panottico, architettura che garantisce l’introiezione completa delle norme e assicura il funzionamento automatico del potere. La disposizione è ancora simile a quella di un panottico settecentesco: il potere centrale rimane inverificabile e costantemente all’opera, gli spazi sono ridotti al minimo e uguali per tutti, gli unici movimenti possibili sono rigidamente stabiliti.
Siamo in un quadrillage che organizza uno spazio analitico cellulare in cui la piattaforma gratuita lavora per impiegare il nostro tempo con le stesse tecniche delle istituzioni disciplinari: stabilire scansioni, costringere a determinate operazioni, regolare il ciclo delle ripetizioni, ridurre il nostro agire in protocolli da seguire. Per ottenere questo tipo di disciplina bisogna usare sapientemente quella che Foucault chiamava l’arte oscura della luce: “essa deve essere come uno sguardo senza volto che trasforma tutto il corpo sociale in un campo di percezione”. È evidente come nel confine panottico, aggregati di individui, anche assai numerosi, possono muoversi come un corpo sociale unico, reagendo agli stimoli proiettandone gli effetti all’unisono su tutte le zone di percezione che trovano. Nel campo dei social media dove la zona operativa centrale è l’emozione, la trasduttività è talmente rapida da propagare una vera e propria infezione somato-psichica che potremmo chiamare endo-colonialismo.
È dunque nostra cura ricordare che la mercificazione del vivente non passa solo attraverso le tecnologie riproduttive, lo sfruttamento animale, la manipolazione delle sementi e lo sfruttamento più o meno schiavile della manodopera, ma passa anche attraverso dispositivi tecnologici progettati per acquisire una delega sull’organizzazione sociale e cognitiva degli umani. È nostra convinzione che questa sia la causa di buona parte della difficoltà di costruire azioni micro-politiche quotidiane volte alla cura di comunità sostenibili e resistenti. Riteniamo che i nuovi femminismi debbano far propria la critica alle tecnologie digitali, senza rinunciare a nulla della gioiosa eredità cyberfemminista e dell’amore per la conoscenza informatica. Occorre certamente studiare da vicino e in senso tecnico gli applicativi e in modo sistemico senza tralasciare i diversi supporti hardware che molto raccontano dell’aspetto geopolitico delle tecnologie informatiche. Dissezionare le interfacce, studiarne l’ergonomia, scoprire come le ideologie siano abilmente inscritte nel design delle piattaforme per diventare prescrizioni etiche, che ripetiamo assieme alle procedure. “Metterci le mani sopra”, praticare la tecnologia è altrettanto importante. Noi prediligiamo l’approccio hacker: stile antiautoritario e diretto dell’apprendere senza maestri, che si affida in primis alla curiosità. Posto di fronte ad un oggetto tecnologico l’approccio di un* hacker non è quello di usarlo, ma di capire come è fatto, di smontarlo, di vedere come funziona. Per un* hacker nessun artefatto è obsoleto perché ogni cosa può essere reinventata con uno scopo anche molto diverso da quello per cui era stata creata.
L’hacking non è inquadrabile in percorsi di studio ufficiali e titoli di studio riconosciuti, è un percorso di ricerca personale che parte dal desiderio di sperimentarsi in prima persona, nella pratica quotidiana. È nel rapporto con gli altri, con la comunità, che l’hacker comincia a ricercare uno stile personale e a formare il suo carattere, il suo ethos.
Ma naturalmente l’amore per la conoscenza ha le sue insidie, sapere è potere, e la padronanza della tecnologia in generale è fonte di potere. Il potere ha un doppio asse, come Braidotti ci ricorda più volte tra le pagine dei suoi studi: coercitivo (potestas), politica gerarchizzata o maggioritaria e creativo (potentia) aion minoritario, forme di divenire diffuse, nomadi e rizomatiche. Chi possiede il sapere dunque, può usarlo per diventare superiore agli altri ed esercitare dominio. La conoscenza delle macchine, in un mondo costruito in larga parte dalle macchine stesse, è il potere più grande che esista oggi. In una società gestita dalle macchine, è logico pensare che chi gestisce le macchine governa la società. Occorre quindi essere consapevoli delle forme di suprematismo che aleggiano negli ambienti informatici dove il desiderio di “rendere il mondo un posto migliore” significa generalmente il desiderio di dominarlo per intero riducendolo a codice binario.
Per questa ragione occorre costruire gruppi di lavoro interdisciplinari il cui compito sia, tra gli altri, di ricordare che la razionalità strumentale non è l’unica forma di conoscenza.
Praticare alternative tecnologiche non significa creare un social network autogestito con un infrastruttura decentralizzata, nella convinzione che il P2P sia la panacea di tutti i mali, ma riconoscere e dividere le funzioni dell’organizzazione da quelle della comunicazione che sono state abilmente sovrapposte al fine di ottenere la resa completa alla governamentalità. Dobbiamo continuare a discutere assieme, in modo da stabilire precisamente che cosa ci serve e ragionare in termini di ecologia della comunicazione, inibendo il più possibile il sistema delle notifiche ed eliminando completamente l’interazione gamificata. Altrimenti saremo condannati a riprodurre la norma tecnocratica attraverso strumenti free software. Solo praticando convivialità tecnologica e hacking del sé i femminismi e i movimenti anti-autoritari potranno trovarsi a usare politicamente l’informatica (e non esserne agiti).
Prioritario è ridurre drasticamente l’uso dei sistemi commerciali (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ecc.) e al contempo immaginare e assemblare tecnologie la cui retroazione non sovrascriva completamente l’etica che cerchiamo di praticare. È faticoso? Lo è solo se si ha la sensazione di una rinuncia punitiva alla comodità meritata, altrimenti è una liberazione di energia creativa – resa possibile dalla mobilitazione del proprio privilegio – che può diventare felicemente improduttiva e darci grandi soddisfazioni politiche.
Ringraziamo Braidotti per tutto il suo lavoro teorico sul nomadismo e il materialismo etico, per la sollecitudine con cui ci richiama a una prospettiva politicamente radicata e anticapitalista che ci è stata di ispirazione sin dagli esordi della nostra pratica collettiva. In particolare la ringraziamo per la generosità con cui ha messo a disposizione ogni elemento del suo il metodo cartografico. Questo fare, che è una pratica discorsiva e un’azione diretta, ci ha permesso di posizionarci di volta in volta come gruppo di ricerca facendo luce sui rapporti di potere nei quali eravamo immersi e sulla necessità di tematizzare l’uscita da una prospettiva esclusivamente tecnica per abbracciare un esercizio interdisciplinare. Il lavoro di Braidotti è importante per tutti i movimenti di resistenza e di liberazione: femminista, transfemminista, queer in primis, ma anche tecnologica, antispecista e ecologista. Siamo certe che questo volume potrà essere utile alle nuove lettrici, in particolare le giovani, per scoprire l’interezza dell’opera di una delle più importanti filosofe femministe della nostra epoca.
Gruppo di Ricerca Ippolita